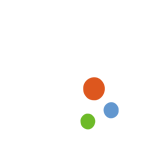Meghni: “Il talento non basta per diventare Zidane. Quanti ricordi con Pioli, Guidolin e Mazzone, tornassi indietro starei a Bologna tutta la vita”
È il 2001, e il popolare settimanale calcistico Don Balón inserisce Mourad Meghni al decimo posto nella lista dei giovani calciatori più promettenti al mondo. Dietro di lui ci sono futuri campioni del calibro di Zlatan Ibrahimovic, Andrés Iniesta, Arjen Robben, Fernando Torres, Kaká e Maicon, ma lì per lì la graduatoria stilata dagli spagnoli regge, perché questo francesino classe 1984 ha due piedi che fanno letteralmente cantare il pallone. Gioca nel Bologna, con cui si è appena laureato campione d’Italia nella categoria Allievi, e lo chiamano Le Petit Zizou. Nato a Parigi ma di origini algerine (che riabbraccerà in Nazionale maggiore), talento smisurato e stesso ruolo, la speranza che si tratti dell’erede di Zinedine Zidane è forte, e lo diventa ancora di più dopo che Mourad vince il Mondiale Under 17 da protagonista. Nonostante l’esordio in Serie A ad appena 18 anni e qualche gol da togliere il fiato, quelle splendide promesse non verranno però mantenute, sostituite da una marea di rimpianti. Oggi che di anni ne ha 36 lo abbiamo finalmente ritrovato, parlando con lui di ciò che non è riuscito a essere ma anche di ciò che è diventato: un ragazzo maturo e il padre di quattro bellissimi bambini, con il calcio e i colori rossoblù sempre e comunque nel cuore.
Mourad, quanto tempo! È stata dura rintracciarti, sei in Francia adesso? «Sì, a Parigi. Ovviamente in casa, aspettando come tutti che questo brutto periodo finisca».
Ci devi aggiornare con precisione sui tuoi ultimi anni di carriera, perché tra calcio e calcetto ne abbiamo sentite dire tante… «Nel 2013, dopo due stagioni in Qatar, avevo smesso per via dei continui problemi alle ginocchia. I dottori mi dicevano che non avrei più potuto giocare a calcio: è stato un momento difficile perché avevo solo 29 anni, mi sono anche operato per fare un altro tentativo ma dopo sei mesi pieni di dolori ho dovuto accettarlo e fermarmi. Un anno e mezzo dopo ho ripreso ad allenarmi qui vicino a Parigi con una squadra di calcio a 5 (lo Champs Futsal, ndr), e vedendo che le cose andavano piuttosto bene ho giocato tre-quattro mesi con loro».
Poi però sei tornato sul rettangolo verde, giusto? «In Algeria hanno saputo del mio ritorno all’attività e il Constantine mi ha proposto di riprovare nel calcio a 11: per me è stata come una rinascita, certo in un campionato non famoso ma comunque molto importante per la gente, con stadi sempre pieni. Dopo due anni lì e con il contratto in scadenza mi sono ritrovato davanti ad un bivio: proseguire in Algeria, dove stavo bene ma non avevo con me la famiglia, rimasta in Francia, o attendere un’altra proposta per avvicinarmi a casa. Un paio di offerte mi sono arrivate ma niente di davvero interessante e stimolante, così a 33 anni ho preferito rientrare a Parigi e smettere definitivamente. Anche se qualche mese fa alcuni amici mi hanno chiesto di dare una mano alla loro squadra, il Val de France, in ottava serie…».
Ecco un’altra notizia importante: hai messo su famiglia. «Sì, sono sposato e ho quattro figli, due maschi e due femmine (che durante l’intervista si fanno spesso sentire, amorevolmente redarguiti dal papà, ndr). Loro sono la mia vittoria più bella».
Da ragazzino, durante gli allenamenti nel ritiro di Sestola, restavo incantato davanti ai tuoi numeri e pensavo: “Questo qui ci porterà lontano”. Perché le cose sono andate diversamente? «Per restare ad alti livelli è fondamentale avere continuità, e io in Italia non sono mai riuscito ad averla. Senza dubbio gli infortuni non mi hanno aiutato: l’unica stagione in cui sono stato bene dall’inizio alla fine è stata quella in B col Bologna, per il resto era uno stop continuo. Alla lunga mi sono un po’ scoraggiato, perché quando non riesci ad esprimerti come vorresti il morale va a zero e anche sul piano mentale è dura rialzarsi. Lì per lì non comprendevo il motivo di tanti problemi fisici, poi ho capito che evidentemente non facevo tutti gli sforzi necessari».
Cosa rimproveri di più a te stesso? «La mentalità che hai da giovane non è la stessa che sviluppi in età adulta: io ero un ragazzo tranquillo ma mi accorgevo di avere dei mezzi tecnici superiori alla media, che mi bastava poco per essere ‘meglio’ degli altri. Sono cresciuto così, senza quella fame e quella voglia di migliorarmi sempre, anche se magari non si notava troppo perché comunque in allenamento mi impegnavo. Se vuoi diventare un campione, però, devi fare molto di più, perfezionare le tue qualità e lavorare sodo sui punti deboli. Io ad esempio correvo tanto ma ero poco esplosivo e mancavo di forza, non avevo un gran fisico ma non mi piaceva andare in palestra, invece era molto importante. Quindi sì, ho le mie colpe».
Ti chiamavano Le Petit Zizou, ed è superfluo spiegare il motivo: quel soprannome è stato più un onore o un onere? «Tutte e due le cose. Da un lato sono sempre rimasto umile e non mi sono mai voluto paragonare a Zidane: se qualcuno mi chiamava così lo ringraziavo ma non me ne fregava nulla, ormai ci avevo fatto l’abitudine. Dall’altro, invece, avendo addosso quell’etichetta ero soggetto a critiche più dure del normale, a giudizi più severi, però avevo 17-18 anni e a quell’età credo sia normale e comprensibile sbagliare. Comunque, essere accostato ad un mostro del calcio è stato anche un piacere e un privilegio, perché voleva dire che avevo delle qualità».
A Bologna hai avuto ottimi allenatori, a cominciare dalla formazione Allievi con cui hai vinto lo scudetto: che ne dici di fare una rapida carrellata? «Pioli è stato il mio primo allenatore in Italia, mi ha insegnato la lingua e mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista, era come un padre. In quella squadra c’erano tanti altri stranieri oltre a me, come Diagouraga, Clayton, Fabre e Runström, ricordo che il mister ci portava a casa sua in piccoli gruppi per parlare un po’ con noi e farci ambientare meglio. Venivo dai settori giovanili francesi, dove si pensa quasi solo al pallone, mentre con lui ho subito percepito quanto il calcio italiano sia diverso, imparando tanto sul piano tattico ma anche mentale».
Di lì a poco, il grande salto… «Fu Guidolin a lanciarmi tra i professionisti e a farmi esordire in Serie A (12 gennaio 2003, Bologna-Milan 0-2, ndr). Tatticamente un maestro, come carattere era però più freddo rispetto a Pioli, parlava poco, ma del resto guidare una Prima Squadra non è come allenare dei ragazzi. Quando parlava, però, era fuori dal comune: in carriera non ho mai sentito dei discorsi prepartita come i suoi, ci davano una carica impressionante».
E arriviamo ad un certo Mazzone. «Qui si parla di un vero e proprio mito, uomo e allenatore inimitabile. Non dimenticherò mai le sue sgridate in romanesco durante le partite, poi però l’arrabbiatura gli passava e il giorno dopo era già pronto a scherzare, aveva sempre una parola buona per tutti. Discorso simile per Ulivieri, persona perbene e tecnico preparatissimo, nella mia ultima stagione sotto le Due Torri mi ha dato tanta fiducia».
Sbaglio o ti stai emozionando nel ripercorrere quegli anni? «Non sbagli. Quando parlo del Bologna sento che sto parlando della mia squadra del cuore, quella a cui sono più legato (la sua voce tradisce una leggera commozione, ndr). Sì, sono di Parigi, il PSG lo guardo sempre e faccio il tifo, ma non è la stessa cosa. Mi dispiace non riuscire a seguire di più i rossoblù, ma qui trasmettono quasi solo le partite di Juventus, Inter e Milan».
So che sei rimasto in contatto con qualche ex compagno di squadra… «Vlado Smit e Claudio Terzi sono due carissimi amici e con loro mi sento spesso, l’anno scorso ho parlato qualche volta anche con Carletto Nervo e mi ha fatto molto piacere».
Domanda d’obbligo ad un ex numero 10: qual è il giocatore che oggi accende maggiormente la tua fantasia? «Quello che mi fa sedere davanti alla TV per guardare le partite è Neymar, che secondo me è un po’ l’erede di Ronaldinho. Negli ultimi anni il PSG è diventato sempre più forte come collettivo, ma è soprattutto lui che fa la differenza. E infatti, quando manca si sente».
Il calcio è un capitolo chiuso o in futuro, con un altro ruolo, potrebbe riaprirsi? «Non chiuderò mai del tutto la porta al calcio, lo amo troppo. Nei due anni dopo il ritiro non ne volevo sentir parlare perché comunque in quel mondo ho visto cose belle e altre decisamente meno, però alla fine è riemersa la passione per il gioco, per i suoi aspetti più veri e positivi. Tornerò, ma non so ancora con quale veste: allenatore non credo, magari procuratore oppure osservatore».
O magari per insegnare a bambini e ragazzi come si tratta il pallone. «Eh, in effetti ci so ancora fare (ride, ndr). Chissà, forse come assistente di un tecnico o all’interno di un settore giovanile potrei cavarmela. Sinceramente devo riordinare un po’ le idee, un passo alla volta spero di trovare la strada migliore per me».
Dal futuro torniamo al passato, ad una gara piena di sogni e illusioni: 25 settembre 2004, Bologna-Roma 3-1. E il mondo scopre Meghni. «Quella partita mi ha fatto conoscere al grande pubblico e ha mostrato a tutti il mio talento, le mie potenzialità. In Francia già un po’ mi conoscevano, ma dopo quella prestazione finii su tutti i giornali e le TV, ancora oggi quando la gente mi ferma è una delle prime cose che ricordano. Fu una serata splendida, una grande vittoria davanti ai nostri tifosi, contro la Roma di Totti e Cassano che l’anno prima era arrivata seconda: è sempre bello rivedere quelle immagini, anche se poi il campionato finì male sia per la squadra che per me».
A distanza di anni, c’è qualcosa che vorresti dire ai tifosi rossoblù? «Premesso che la maggior parte di loro mi ha sempre sostenuto, dopo la retrocessione in B del 2005 c’è stato un momento in cui non ci siamo capiti e ci siamo allontanati: mi è dispiaciuto molto perché sono passato per un menefreghista, invece ho un carattere sensibile e affettuoso. Ero andato via (in prestito al Sochaux, ndr) e adesso non mi nascondo, ma diciamo che quando sei giovane tendi a fidarti troppo del tuo entourage e a fare qualche scelta sbagliata. Al mio ritorno l’estate successiva sono stato accolto un po’ male, ma ormai è acqua passata, Bologna è nel mio cuore e ovunque sono stato ne ho sempre parlato benissimo, raccontando a tutti che città meravigliosa sia. Ne approfitto allora per salutare i bolognesi e dirgli che gli voglio tanto bene».
Bologna è unica, c’è poco da fare… «Ho sempre sentito dire: “Quando vai via da Bologna capisci ancora di più quanto si sta bene lì”. Io me ne sono accorto, l’ho provato sulla mia pelle, a Roma per esempio ho vissuto una bella esperienza ma niente di paragonabile a Bologna. Ormai non si può più tornare indietro, ma se oggi mi dicessero di ricominciare dall’inizio la carriera e restare tutta la vita a Bologna firmerei subito. Per uno sportivo professionista non c’è niente di più importante che trovarsi bene in un ambiente, inteso come club e città. Io l’ho capito troppo tardi, ma i ricordi non me li porta via nessuno».
Simone Minghinelli
© Riproduzione Riservata
Foto: actufoot.com