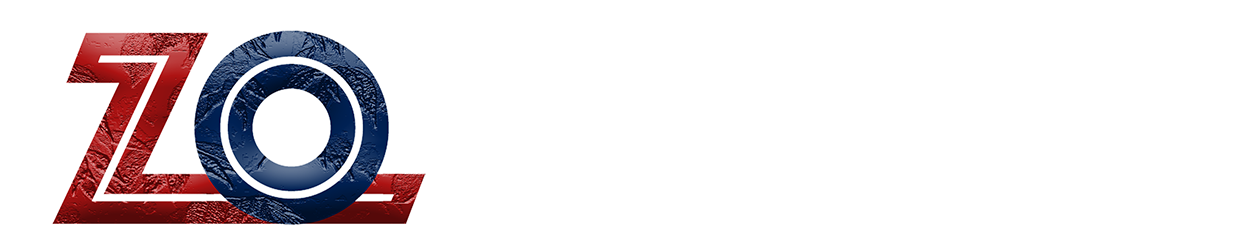Meta della prima tournée intercontinentale del Bologna nel 1929. Secondo Stato più esteso dell’America meridionale. Terra promessa per emigranti italiani, compreso il fratello di Angelo Schiavio, Ercole. Eppure l’Argentina, più che un serbatoio di campioni per il club felsineo, si è quasi sempre rivelata una tonante delusione. Non lo furono certo i primi rappresentanti dei quattordici calciatori argentini sbarcati nel capoluogo emiliano, ovvero i tre talentuosi fratelli Badini (Angelo, Emilio e Augusto), tutti originari di Rosario. Peraltro Emilio, nel 1920, fu anche il primo rossoblù convocato in Nazionale. Dopo di loro arrivò però l’infornata uruguagia dei Sansone, dei Fedullo e degli Andreolo, i maestri indiscussi della stagione d’oro e dello «squadrone che tremare il mondo fa».

Fonte: archiviotimf.blogspot.com
Per ritrovare un argentino sotto le Due Torri bisogna attendere il Secondo dopoguerra, con la resistibile ala Hugo Giorgi (5 gol in 22 presenze dal 1947 al 1949), la meteora René Seghini (forse il bidone più clamoroso dell’era Dall’Ara), la mezzala Humberto Maschio (13 reti in 43 presenze dal 1957 al 1959) e la fugace apparizione, durata appena 45 minuti, di Michele Morra, pescato dal Forlì in Serie C nel 1978. Solo con gli anni Duemila, mentre i migliori albicelesti prendevano la strada di Napoli e Roma, l’Argentina tornerà a far parlare di sé a Casteldebole: accadrà con l’acquisto di Julio Ricardo Cruz (27 reti in 88 partite), di fatto già ampiamente europeizzato grazie alla sua precedente esperienza al Feyenoord, e ancor oggi il miglior argentino transitato in questi lidi. Il suo più vicino ‘erede’, Jonathan Cristaldo, ha chiuso la sua unica annata rossoblù con una retrocessione, quella che invece ha evitato varie volte Rodrigo Palacio, l’unico in grado di reggere il confronto con Cruz.

Fonte: Getty Images
Non sarà facile per Nicolas Dominguez, detto ‘El Principe’, confrontarsi con questi precedenti. Certo, ci sono molti modi per guadagnarsi un soprannome così altisonante. Il giallorosso Giuseppe Giannini, 318 presenze in Serie A con la Roma dal 1981 al 1996, ci riuscì per il suo modo elegante di correre a testa alta. Fu il suo compagno di squadra Odoacre Chierico a battezzarlo così, a metà degli anni Ottanta. E mai epiteto fu più azzeccato. Giannini, come Roberto Mancini, era la punta più nobile dell’Italia post Mondiale, il necessario cambio generazionale nel passaggio da Enzo Bearzot ad Azeglio Vicini. Un centrocampista moderno, che potrebbe tranquillamente trovar posto anche nel calcio di oggi. Non il solito mediano tutto muscoli e poco cervello, ma nemmeno il regista filiforme e svenevole. Era, in sostanza, tutte e due le cose insieme, grinta e qualità, un po’ come i tratti accennati in questi primi mesi da Dominguez, un altro ‘Principe’, come lo hanno battezzato qualche anno fa i tifosi del Vélez Sarsfield con la complicità dell’immancabile telecronista che funge da cassa di risonanza. ‘El Principe’ non tanto per l’occhio azzurrissimo (sarebbe stato fin troppo scontato), ma per il modo con cui di solito si avventa sulla palla, come se volesse salvare una principessa dalle grinfie del cattivo di turno.

Fonte: Imago Images
Invece il buon Nico non si è fatto pregare molto prima di essere acquistato dal Vélez, la squadra che lo ha cresciuto e reso calciatore vero. Per venire a vivere in Italia ha scelto di trasferirsi in pieno centro storico (cosa abbastanza inconsueta per uno straniero alle prime armi), preferendo la scomodità della ZTL alla praticità della Meridiana. In Argentina, invece, il futuro ‘Principe’ era nato ad Haedo, sobborgo di 38.000 abitanti nella fagocitante provincia di Buenos Aires, di fatto un addentellato urbano della capitale sviluppato sull’avenida Rivadavia, l’arteria stradale che unisce il cuore centrale con l’ovest dell’area metropolitana.

Fonte: clarin.com
Potrebbe essere Haedo uno degli scenari immaginati per María de Buenos Aires, la protagonista dell’omonima opera di Astor Piazzolla, di cui proprio quest’anno ricorrono i cent’anni della nascita. Sul palcoscenico, María è l’operaia travolta dai suoni seduttori del tango, in una città proteiforme e tentacolare che prima la trasforma in cantante e poi in prostituta. La sua morte, in piena sintonia col realismo magico sudamericano, uccide il suo corpo ma non il suo spirito: esso continua a vagare sotto forma di spettro in una metropoli affollata di perditempo, ladri e assassini, finché anche l’anima non si reincarna in una nuova María, che dà alla luce una bambina, ovvero una nuova sé stessa, condannata all’eterno ritorno delle cose. Spietato e poetico, questo dramma debuttò nel 1968 a Buenos Aires unendo sacro, profano e fantastico, un mondo in cui si nasce sotto cattiva stella solo «quando Dio è ubriaco». La bolognese d’adozione Milva ne sarebbe diventata, oltre che la dedicataria, anche una delle migliori interpreti. Il tango, ipnotico e rapinoso, scandisce sempre l’alternarsi di vita e di morte come un giudice inflessibile. Chissà se anche Dominguez riuscirà a sfuggire alla ‘maledizione’ che grava sugli argentini rossoblù.

Fonte: azopera.org
Luca Baccolini
© Riproduzione Riservata
Foto copertina: Imago Images