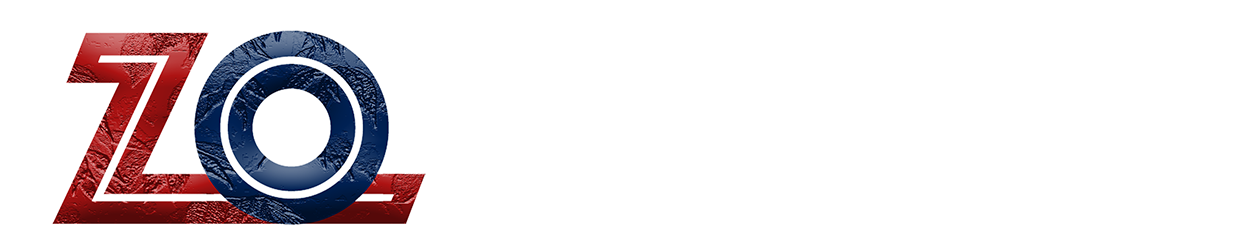«Baciarsi è più intimo che scopare». [Charles Bukowski]
Menarini era il ricco tra di noi. Della stessa età di Màppede, che però aveva dormito per anni sotto i portici del Falcone prima che lo prendesse in casa l’Anita d’i can, egli abitava nell’adiacente Loderingo degli Andalò, dove suo padre aveva uno studio da commercialista col quale teneva le redini della intera pletora dei mediatori del circondario. Inoltre egli era un privilegiato perché lavorava nel Palazzo Ranuzzi antistante i Mirasù, la sede del Tribunale di Bologna. Di corporatura pingue e con gli occhiali tondi, egli era un po’ anche il ghiottone della compagnia ed è in questa veste che lo portiamo ad aprire questo capitoletto. Bisogna sapere che egli era innamorato della Biondina, una sua collega che io ho conosciuto solo con questo nome. Inoltre è essenziale sapere che egli viaggiava sempre con una valigetta ventiquattrore da cui non si separava mai, neanche per andare in bagno. Pare che un giorno la Biondina, che doveva essere proprio perfida, con un temperino della scrivania gli aprì questa misteriosa valigetta, e dentro che cosa c’era? C’era un cotechino col purè, che sua madre gli preparava tutte le mattine. Per anni si ghignò su questo fatterello prontamente diffuso dalla sollecita impiegatina, ma la versione più impertinente era quella di Baccilieri: recitava che ad una cert’ora del mattino Menarini si appartava in bagno, apparecchiava il water e faceva colazione con un cotechino.
Ma venne il giorno che Menarini trovò la macchina e andammo tutti alla Lucciola di Castel d’Aiano. Recentemente un residente di quelle parti mi ricordava che un locale di quel nome non era a Castel D’Aiano ma più in là, a Ca’ di Bandoni, dove all’epoca secondo me finiva il mondo.
Andammo tutti ma tranne Baccilieri, che era invece partito in treno a giocare al casinò di Venezia proprio con i soldi che gli aveva dato Menarini. E con quelli di una figa che lo aspettava all’attracco del vaporetto veloce. Lui poteva entrare, perché era abituato a dichiarare più anni della sua età.
Erano le prime volte che approdavo alle discoteche, luoghi che non posso dire siano mai più stati d’elezione per il mio carattere. Io non ero infatti capace di ballare, né ho più saputo neanche in seguito educare il mio corpo a muoversi in accordo a quel ritmo che pure mi prendeva e immaginavo avrebbe potuto far turbinare anche me con quelle ragazze leggere che il suono muoveva e che come le falene delle feste del Grande Gatsby erano fiato, erano luce, erano vento che palpitando avvolgeva le figure trascinato dal ritmare del twist.
Poco importava che vivessi la situazione come in una sorta di impotenza, come un amore impossibile a consumarsi: se la fanciulla incrociava lo sguardo io l’abbordavo: «Permette un ballo?». E qui succedeva una cosa incresciosa e cioè che le interpellate, dopo essersi protese a me con una fiducia che mi pareva miracolosa, ma che era anticipo di fallimento, altrettanto velocemente cercavano di filarsela non appena le accompagnavo in pista. E peggio ancora se cercavo di ripiegare facendole sedere a tavolino intavolando una conversazione. Dopo avermi messo gli occhi negli occhi, queste poi si mettevano a guardare da tutte le parti, segno che la mia conversazione non poteva interessarle di meno. L’inghippo stava in un’altra impotenza. «Devi saper fare l’asino per tutta una sera», argomentavano i miei amici che erano in sintonia con l’immanenza delle cose: ma questo, mi rendevo conto, era una dote sorgiva della terra, come l’acqua delle fonti.
Certo, io e Budellacci avevamo difetti contrari. Lui era un buon ballerino e avrebbe voluto ballare a tutti i costi. Ma già che gli mancava un occhio e mezzo e forse non era stato bello neanche in partenza, nessuna voleva ballare con lui. Budellacci però, ad un certo punto della serata, ebbe un moto di ribellione che fece epoca. Incassato l’ennesimo rifiuto, si mise al centro della pista, inchiodò con l’indice una ragazza e così la apostrofò:
«No! Té ‘t bâl! Parché mé a j ò paghè al bigliàtt!».
Ma al girare di un lento, mi presentai ad una ragazza che aveva dato fin lì parecchi rifiuti. Era bionda cotonata, aveva la faccia simpatica e vestiva di un completo nero. L’unico difetto erano le caviglie non proprio sottili che si esibivano tra le scarpe coi tacchi e i pantaloni stretti. Anch’io vestivo elegante, indossando il gessato che mi ero portato da casa.
L’accompagnai in pista tenendole la mano destra con la sinistra quindi, come si faceva, le circondai la vita con la destra. Aveva un corpo forte, ma il suo profumo era buono.
«Come ti chiami?».
«Vanessa, e tu?».
Avevano messo un pezzo che imperversava con il sax.
«Ti piace Fausto Papetti?», le chiesi all’orecchio.
«Oh, a me sì», e il tono dell’esclamazione soavemente mi coinvolse.
Allora la circondai anche con la sinistra e la strinsi con tutto il corpo, mentre qualcosa mi succedeva giù nell’inguine che s’andava insinuando perentorio tra me e la Vanessa. Lungi dal ritrarsi come avrei temuto, lei accentuò l’onda ritmica del pezzo musicale e in quel momento il mio disappunto fu di non poter apporre i ventun centimetri di Henry Miller. Quasi all’ultimo giro di sax la Vanessa mi cacciò la lingua in bocca. Non ero troppo esperto di baci: dopo aver trafficato con un certo smarrimento in tondo e in largo con la mia di lingua, quando al fine catturai la sua improvvisamente qualcosa di perentorio mi esplose giù in fondo. C’è poco da dire e non andai certo a verificare. Abbacchiato riaccompagnai la Vanessa in poltrona, vergognoso che lei potesse avere capito. Ci dicemmo di noi e di quello che facevamo, lei era di qualche anno più grande di me, ne aveva diciotto. Menarini doveva riportare giù la macchina. Con prestidigite dita, lei ridendo mi scompigliò la capigliatura: ecco era lì la mia forza.
«Torni la prossima domenica?».
«Di sicuro, di sicuro, torno coi miei amici!».
Avevamo tutti bevuto qualcosa, anch’io avevo preso un whisky. Menarini, da folle, mi lasciò la guida della Fiat 1100 al ritorno a Bologna. Màppede si era addormentato. Menarini e Moreno se la raccontavano. Io, prima di allora avevo guidato solo sul prato di casa la 500 nuova assieme a mio fratello maggiore.
Si innalzava e si abbassava, si nascondeva e riproponeva il profilo placido delle colline, come fossero animali adagiati, mentre scendevo angosciato per la Porrettana. Correvano sulla luna stracci di nuvole nere come pescecani. Giravano e si ritorcevano, salivano e scendevano i tornanti, finché non comparve verso Casalecchio il profilo domestico di San Luca. Lo sa Dio come non avessi condotto la compagnia giù per qualche calanco. A notte fonda sognai la Vanessa. E ancora tornanti e cabine minacciose di autotreni che mi venivano addosso. E dietro ad ogni curva compariva un cartello: Qui Ca’ di Bandoni, finisce il mondo.
Bombo
Questa è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, istituzioni, luoghi ed episodi sono frutto dell’immaginazione dell’autore e non sono da considerarsi reali. Qualsiasi somiglianza con fatti, scenari, organizzazioni o persone, viventi o defunte, veri o immaginari, è del tutto casuale.
© Riproduzione Riservata
Foto: youparti.com