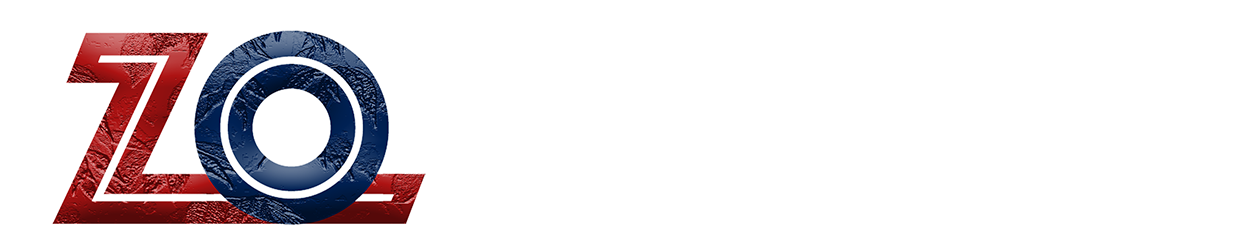Secondo capitolo: Il jukebox
A più riprese nel corso degli anni ho pensato che la mia generazione, quella nata attorno alla fine della guerra, abbastanza tardi quindi per fare in tempo a subire i bombardamenti e patire un po’ di fame, che per la prima volta da che mondo è mondo non si è grattata i pidocchi e non è saltata sulle pulci, che per prima schivò endemiche malarie e striscianti pandemie tubercolari, che per prima fu avviata alla scuola in modo massiccio, in anticipo inoltre di quel tanto da essere esentata dal pedaggio di scontarne il privilegio con flagelli anoressobulimici, sia stata la più fortunata e la più bolsa che mai sia comparsa sulla Terra.
E la fortuna supplementare per cui la morale corrente era presso di noi ancora ben definita, essendo rimasta sostanzialmente quella dei genitori, va tenuta bene in conto per capirne la vicenda, meno epica di quanto non si immagini. La serena accettazione delle possibilità familiari contemperava ambizioni di cauto ottimismo: il lavoro fisso, uno stipendio buono, una casa, una famiglia stabile. Mentre l’adesione politica era sentita come giusta e funzionale nella misura in cui era giusto un miglioramento generale delle condizioni.
Fu con questo patrimonio di salute e stabilità morale che la mia generazione accedette alle vicende del Sessantotto: una rivoluzione perfettamente riuscita e dentro la quale ancora vivono i nostri figli già grandi come somari e i pischelli nostri nipoti e pronipoti. Ma cosa fu questo Sessantotto? Adesso poi ne parliamo, un po’ di pazienza. Provo solo ad anticipare, e mi scappa un poco da ridere, che da noi fu innescato da un prete con una lettera ad una professoressa per un verso, e dall’invenzione della pillola anticoncezionale dall’altro. Venne però d’oltre Atlantico, pervase l’Occidente, e rispondeva all’esigenza di consumare le merci che la Quarta rivoluzione industriale andava producendo. Beh meglio così, i consumatori dovevamo essere noi, nati vent’anni prima.
A volte si dice la mutazione antropologica, per cui la gente cambia e se ne va per un’altra strada. E siccome la gente non cambia a capocchia ma bensì tutta assieme e tutta in un modo, io ho sempre pensato alla freccia del tempo, il processo inarrestabile delle rivoluzioni che chiamammo industriali pre e post, le quali cambiano le teste con scappellotti estranianti.
A un certo punto mi prese vertigine, pensando a quegli anni Sessanta in cui ci immaginavamo già fatti e definitivi, quanto poco tempo ci separasse in realtà dalla fine della guerra che per ultima ci aveva generato e che quando comparve il primo jukebox sul retro dei bar vicino casa, gli americani avevano finito di traslocare la loro serpentiforme ferraglia lungo le strade della mia bassa da meno tempo di quanto ne sia passato oggi dalla comparsa del primo smartphone sensibile al tocco. E infatti, venticinque anni ancora e uno avrebbe cantato: «Gli americani che, proprio ieri sono andati via».
È certo che avevamo nozioni di una remota barbarie che ci aveva preceduto e che noi stavamo vivendo un’età autentica, nel modo certo dei ragazzi di ogni generazione: chi è giovane è giovane e chi è vecchio è vecchio e il mondo è un eterno presente. Anche se in effetti, quarant’anni ancora e qualcuno assai avveduto avrebbe definito quegli anni l’età dell’oro.
Dicevo, il jukebox.
A volte mi prende convinzione che quel dio luccicante, la cui voce consiglio a tutti di riascoltare presso qualche antiquario o collezionista, con le dita delicate della sua leva meccanica girò pagina per noi e dopo più nulla fu uguale o non accadde più nulla. Così come quelli appena più giovani di me avevano pensato che fu il boogie a cambiare il mondo e che fu dopo di esso che non accadde più nulla. Quel che è certo è che si ballò per i bar un nuovo ritmo, che però replicava canti che dovettero essere canti nuovi, quando nella notte dei tempi il primate uscì dalla foresta per la prima volta, o quando si mise a mungere la prima pecora o quando gli girò di incidere la prima tavoletta o quando si mise a far andare lo stantuffo a vapore.
Il fatto è che in quegli anni di euforia post bellica, dalle nostre parti del mondo cosiddetto primo e sviluppato eravamo nati in tantissimi, e non so in quanti destinati a cantare poi la famosa canzone in gloria del Cavaliere. Ma questo è un altro discorso. E crescemmo tutti simili tra di noi senza conoscerci, dall’Australia, all’America, alla Scandinavia, tutti più o meno poveri, tutti più o meno ricchi mangiando le stesse vitamine, con famiglie che avevano gli stessi problemi. Finché ci trovammo allo straordinario appuntamento planetario con le note dei quattro di Liverpool. Certo, i Beatles fecero il Sessantotto prima del Sessantotto. Love Me Do si ascoltò nel metrò di Londra, si ascoltò nei quarantacinque giri accanto ai ribaltabili delle Cinquecento, non finiva di suonare nei pullman delle gite scolastiche, se lo regalavano a vicenda i fidanzatini nazionali ed internazionali che si conoscevano al mare cominciando a spuntare da tutti i continenti. Eravamo proletari di tutto il mondo ed eravamo uniti, finalmente, nel nome di John Lennon e Paul McCartney.
Come altre volte doveva accadermi, io non capii subito.
Continua…
Bombo
© Riproduzione Riservata
Foto: grandvintage.it